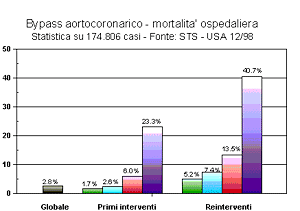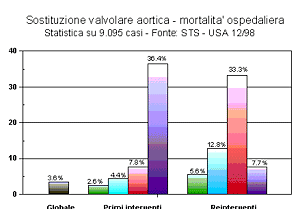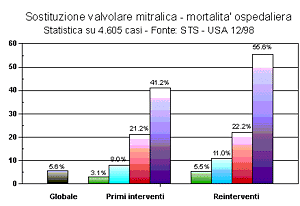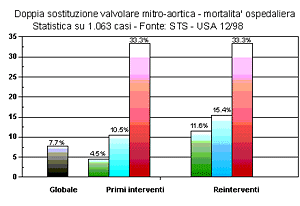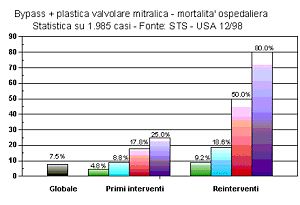PRESTAZIONI

Cardiochirurgia
Sostituzione valvola aortica
La valvola aortica è posta tra il ventricolo sinistro e l'arteria aorta. Il ventricolo sinistro è la parte del cuore che ha il compito di pompare il sangue ossigenato a tutto il corpo attraverso l'aorta. La valvola aortica si apre durante la sistole ventricolare (cioè nel momento in cui il cuore si contrae per pompare), lasciando passare il sangue nell'aorta, e poi si richiude, impedendo al sangue di ritornare nel ventricolo durante la diastole (cioè durante la fase di rilasciamento e riempimento che precede la contrazione successiva. In questo disegno l'aorta è colorata in rosso e la valvola si trova all'inizio dell'aorta, nel bulbo.
La valvola aortica può ammalarsi per diversi motivi: vi può essere una anomalia congenita che può richiedere la correzione subito, se grave, oppure predisporre ad una degenerazione che avviene più tardi nella vita; oppure vi possono essere delle malattie acquisite che colpiscono la valvola aortica. L'anomalia congenita più frequente è data dalla bicuspidia.
In genere la valvola aortica ha tre lembi valvolari o cuspidi, ma a volte può presentarne soltanto due. Una valvola bicuspide è presente nell'1 - 2% della popolazione, e rappresenta la seconda causa più frequente di alterazione tale da richiedere l'intervento. Queste valvole possono funzionare relativamente bene per molti anni prima di diventare stenotiche (cioè con un orifizio troppo stretto) oppure insufficienti (cioè non più in grado di chiudersi bene).
La causa più frequente di malattia valvolare necessitante la sostituzione è la degenerazione senile. Questo significa semplicemente che la valvola, invecchiando, si indurisce e vi si depositano noduli di calcio che ne impediscono il funzionamento. La seconda causa più frequente è la malattia reumatica, che provoca fusione e retrazione cicatriziale dei lembi, lasciando una valvola allo stesso tempo stenotica ed insufficiente. Altre cause meno frequenti di valvulopatia aortica comprendono le infezioni (dette endocarditi), il prolasso di una cuspide e le malattie dell'aorta stessa, come aneurismi e dissezioni.
Una valvola aortica malata può causare una serie eterogenea di sintomi, che comprendono affaticabilità, dispnea da sforzo, angina pectoris, palpitazioni, vertigini e sincopi.
Quando la valvola è stenotica il ventricolo sinistro deve generare una pressione più alta per spingere il sangue a tutto il corpo. Questo causa ipertrofia (cioè ingrossamento) del muscolo cardiaco, predisponendolo ad aritmie ed allo sviluppo di sintomi di angina. Inoltre il ventricolo non si svuota completamente, e questo ristagno di sangue eventualmente si ritrasmette all'indietro fno ai vasi dei polmoni, causando dispnea (difficoltà di respiro) dapprima da sforzo e poi anche a riposo. Infine, in particolari situazioni il cuore può non riuscire a pompare abbastanza sangue per mantenere normale la pressione sanguigna nelle arterie (in particolare quelle del cervello), e questo causa vertigini e sincopi (svenimenti). Quando invece la valvola è insufficiente, parte del sangue pompato ritorna nel ventricolo sinistro causando un sovraccarico di volume e poi una dilatazione del ventricolo stesso. La dilatazione a lungo andare provoca uno sfiancamento delle pareti e l'insorgenza di sintomi di scompenso cardiaco.
Inizialmente i sintomi sono presenti sotto sforzo, ma col progredire della malattia compaiono per sforzi sempre più lievi ed infine anche a riposo. Questo può causare l'impossibilità a dormire in posizione orizzontale o portare a bruschi risvegli per la difficoltà di respiro. Un altro segno di scompenso è il gonfiore alle caviglie, specialmente alla sera.
I farmaci possono aiutare per un certo periodo ad alleviare i sintomi, ma quando la funzione valvolare decade, il Vostro cardiologo Vi raccomanderà di andare dal cardiochirurgo per programmare l'intervento. Alcuni test (ecocardiogramma, cateterismo cardiaco con coronarografia) aiuteranno a stabilire il momento più adatto per l'intervento e ad escludere eventuali patologie concomitanti (per esempio una coronaropatia).
In linea generale vi sono due tipi di protesi valvolari oggi disponibili, ognuna con pregi e difetti caratteristici: le protesi MECCANICHE e le protesi BIOLOGICHE.
Le protesi valvolari meccaniche sono caratterizzate dall'ottima durata dovuta alla durezza dei materiali che le compongono. Infatti sono costituite da un anello in lega d'acciaio ricoperto di carbonio e da due foglietti mobili anch'essi in carbonio. Questo materiale non si consuma e quindi la durata di una protesi meccanica è praticamente illimitata. Il principale svantaggio di queste valvole è dato dalla necessità di mantenere il paziente sotto terapia anticoagulante per tutta la vita. Infatti il sangue, a contatto con il carbonio (come con qualunque materiale artificiale) tende a formare dei coaguli che potrebbero attaccarsi alla valvola bloccandone il funzionamento. Il paziente dovrà quindi assumere ogni giorno una certa dose di farmaco anticoagulante e dovrà sottoporsi regolarmente (ogni 3-4 settimane) ad un prelievo di sangue per il controllo del livello di anticoagulazione (se troppo basso, il sangue coagulerà ugualmente, se troppo alto c'è il rischio di emorragie).
Le protesi valvolari biologiche, invece, sono costruite partendo da valvole cardiache (o da altri tessuti come la membrana pericardica) di animali (bovini e suini). Queste valvole richiedono una terapia anticoagulante solo per un breve periodo (in genere 3 mesi). Infatti il sangue non tende a coagulare a contatto di questi tessuti. Il loro principale svantaggio consiste nel fatto che la loro durata nel tempo è limitata, ed è inversamente proporzionale all'età del paziente. In un paziente giovane (sotto i 40 anni), queste valvole durano 8-10 anni al massimo, mentre in uno anziano possono durare anche 15 anni (in rari casi anche di più). Questa differenza è data dal metabolismo del calcio, che nel giovane è più attivo e tende a depositarsi nei foglietti valvolari causandone l'indurimento.
Le protesi biologiche più recenti sono trattate con particolari sostanza chimiche allo scopo di ridurre la deposizione di calcio sulla superfice dei foglietti; questi trattamenti hanno mostrato in studi sperimentali la capacità di aumentarne la resistenza alla calcificazione e quindi la durata. In casi particolari possono essere utilizzati altri tipi di protesi, come gli homograft aortici (prelevati da cadavere umano), oppure si può utilizzare un'altra valvola dello stesso paziente e metterla al posto della valvola aortica malata (intervento di Ross). La decisione sul tipo di valvola da utilizzare viene presa dal team medico tenendo conto dell'età del paziente, delle sue condizioni generali, del suo stile di vita ed anche delle sue preferenze.
I rischi dell'intervento di sostituzione valvolare aortica vengono stimati dal cardiochirurgo e dall'anestesista in base ad una moltitudine di fattori.
Nei grafici dei risultati sono mostrate le analisi statistiche compiute dalla STS americana su una moltitudine di pazienti operati in anni recenti.
Dopo la fase di convalescenza e di riabilitazione, i pazienti operati di sostituzione valvolare in genere godono di una importante riduzione della sintomatologia e di un netto miglioramento della capacità d'esercizio e di tolleranza agli sforzi. Possono essere necessari fino a 2 - 3 mesi dall'intervento per un completo recupero. Dopo la guarigione della ferita sternale, in genere non vi sono limitazioni importanti all'attività fisica, se non quelle legate all'assunzione di anticoagulanti. è necessaria la profilassi antibiotica prima di ogni procedura invasiva (compresa la rimozione del tartaro dentale), ed è buona norma avere nel portafoglio un cartellino che identifichi la persona come portatore di protesi valvolare cardiaca.
Intervento di sostituzione valvola aortica per calcificazione
Intervento di plastica aortica